#46 The starting point is giving a damn
Cioè, si inizia quando ce ne frega qualcosa. Anche un minimo, ma è pur sempre qualcosa.
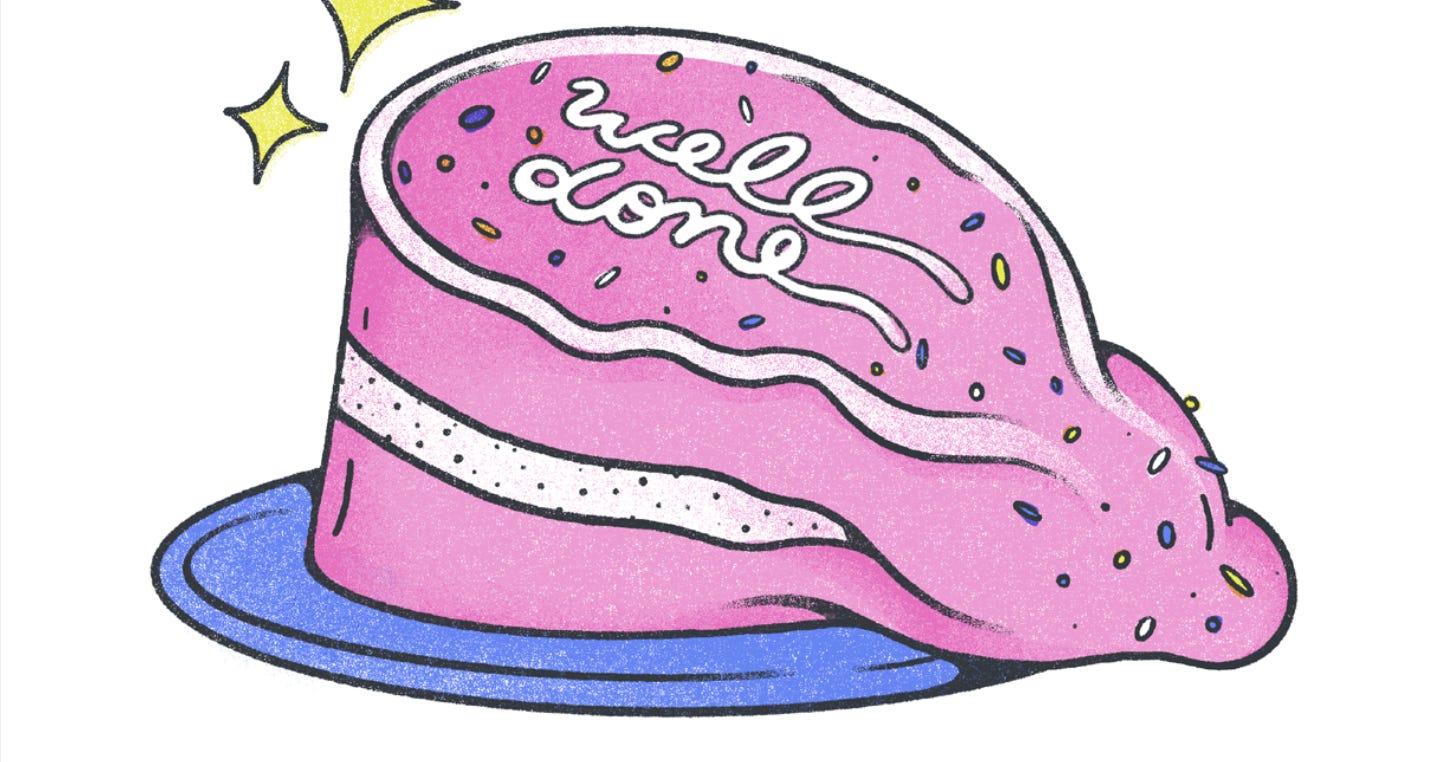
Due giorni fa ho letto un ebook di Sheri Byrne-Haber, grandissima esperta di accessibiltà digitale e autrice di centinaia di preziosi articoli e tutorial sul tema: si chiama Giving a damn about accessibility. A candid and practical handbook for designers, ed è un breve ma puntuale compendio di tutto quello che è necessario sapere per iniziare a pensare in modo accessibile, soprattutto se si lavora nella progettazione di esperienze digitali.
Il libro inizia con questa massima:
Non è la tecnologia a rendere complicata l'accessibilità, ma la gente che se ne frega.
Segue una concisa (e anche divertente) presentazione delle categorie di persone che è frequente incontrare quando si cerca di introdurre il tema dell’accessibilità in un progetto o in un contesto aziendale:
Quelle allergiche al cambiamento. Sì, hai indovinato, le persone che si trincerano dietro gli “abbiamo sempre fatto così.”
Quelle che hanno bisogno del business case per capire se ne vale davvero la pena. Perché cercare il beneficio economico senza il quale l’accessibilità è considerata una mera voce di spesa senza ritorno è, semplicemente, un atteggiamento abilista.
Quelle che preferiscono dare priorità alla creazione di nuove funzionalità inaccessibili invece che rendere accessibili quelle già esistenti. Tipo quando Twitter lanciò le note vocali nel 2020 senza alcun supporto per le persone sorde o ipoacusiche.
Quelle che “tanto le persone con disabilità sono solo una piccola nicchia di utenti”. E quindi lavorare sull’accessibilità non avrebbe un effettivo ritorno economico. Eppure tanto piccola non sembra, questa “nicchia”.
Quelle che non credono che le persone con disabilità facciano parte del loro target o base clienti. Una fallacia logica: se produciamo un prodotto inaccessibile, come possono le persone con determinate disabilità entrare a far parte del nostro pubblico di riferimento? Ma anche: da dove deriva l’idea sbagliatissima che le persone con disabilità non siano anche consumatrici?
Quelle che hanno installato un plugin o un widget per rendere più accessibile il loro sito web e pensano di poter chiudere così il discorso. Fabrizio Caccavello spiega con molta chiarezza perché questi strumenti non possono essere la soluzione per rendere un sito web accessibile.
Le categorie di persone che ho incontrato più spesso nel mio lavoro sono la 4 e la 5. Negli anni ho annotato molte delle loro affermazioni e credenze, e in qualche modo le ringrazio per avermi dato così tanto materiale su cui riflettere (e su cui costruire le mie formazioni).
E poi un mea culpa: agli inizi della mia esperienza professionale con WordPress, per esempio, anche io ero convinta che un plugin o un widget sarebbero stati sufficienti. E invece: quante cose avevo ancora da imparare!
L’insegnamento principale che voglio condividere del libro di Sheri Byrne-Haber, però, è questo:
Accessibility is like speaking a foreign language or playing the violin. It takes a lot of practice before you are any good.
(L'accessibilità è come parlare una lingua straniera o suonare il violino. Ci vuole molta pratica prima di farlo bene.)
L’accessibilità non è qualcosa che si impara in un lampo o seguendo una checklist in 10 punti. Quando studiamo una lingua straniera o uno strumento musicale andiamo avanti per gradi: partiamo dalle frasi o dagli accordi più semplici, poi con il tempo e la pratica prendiamo confidenza e miglioriamo. Con l’accessibilità succede lo stesso, ci vuole un sacco di pratica prima di farla bene.
E anche:
You first attempt at making anything accessible will be awful. Don’t use this as an excuse. Even awful is better than 98% of what other people are doing.
(I tuoi primi tentativi con l’accessibilità saranno pessimi. Ma non usare questa cosa come scusa. Anche se pessimi, i tuoi tentativi sono meglio del 98% altrui.)
Con questa percentuale l’autrice si riferisce al fatto che nel 2021, quando ha scritto il libro, il 98% dei siti web non rispettava le linee guida di accessibilità (Web Content Accessibility Guidelines o WCAG). Oggi il dato è leggermente migliore ma ugualmente sconfortante: il 96% dei siti web online non rispetta gli standard WCAG. 😓
Il primo passo per migliorare le cose, quindi, è iniziare con qualcosa di piccolo, ma comunque iniziare.
Se lavori con le parole e vuoi capire come scrivere testi digitali più accessibili, di qualsiasi tipo essi siano, ne parlo in un webinar gratuito mercoledì 26 aprile alle 17:00 sul canale degli Accessibility Days.
Due cose da leggere, una da vedere, una da ascoltare. E una curiosità catalana per finire.
La lingua di mezzo è un bell’articolo di Stella Sacchini per Il Post: parla del viaggio che fanno le lingue quando vengono usate, rimaneggiate, plasmate, da persone che non le parlano nativamente.
«Succede qualcosa all’italiano, quando a usarlo è una persona che non è nata e cresciuta parlandolo e scrivendolo. Per queste persone l'italiano è una terra straniera in cui si muovono da intrusi. Ma questo vale anche nel senso contrario: da un certo punto in poi, anche l’italiano vive in loro come un intruso. Di certo questa presenza straniera cambia il loro mondo, ma anche quello di chi ha l’italiano come lingua madre.»
«Oggi è importante essere razzisti senza sembrarlo. — dice la scrittrice Djarah Kan nel suo ultimo post su Instagram — Ne va del futuro del razzismo stesso, che come si vede chiaramente da scatti come questi, tende sempre a negare la sua vera natura. Giorgia Meloni non direbbe mai di se stessa che è una persona razzista.»
Kan lo ha scritto per commentare la foto della Presidente del Consiglio che abbraccia dei bambini ad Addis Adeba, durante la sua visita in Etiopia. È un post che ti consiglio di leggere e interiorizzare, anche per formulare la risposta a una delle obiezioni più frequenti di chi non vuole accettarlo: sì, l’Italia è un Paese razzista. (Sara, che proprio qualche giorno fa mi hai scritto per chiedermi un consiglio su come rispondere a chi nega questa evidenza: ecco, Djarah Kan ha messo tutto in fila.)The Trainee è una performance dell'artista finlandese Pilvi Takala, che ho scoperto grazie a chissenefrega, la newsletter di
.
Takala finge di essere una stagista che si aggira tra gli uffici di una multinazionale, ma si comporta in modo strano: non lavora, non usa un pc, passa il tempo a pensare. E lo dice senza timore. La confusione e il senso di resistenza (che sfocia in rifiuto) delle persone dell'azienda di fronte al suo comportamento anomalo sono palpabili. È la difficoltà che proviamo di fronte a chi, pur non danneggiando nessuno, mette in discussione le strutture sociali e le verità acquisite che consideriamo immutabili. È la rottura del codice di appartenenza sociale a mandarci in confusione.Perspective è un progetto musicale di Molly Joyce, compositrice e performer statunitense. Iniziato nel 2020 e ancora in corso, Perspective raccoglie e musicalizza le interviste di persone disabili che rispondono a una domanda: cosa significano per te le parole accesso, cura, interdipendenza, isolamento, forza, resilienza? (Grazie a Tristan per avermelo segnalato, tempo fa.)
Da Sant Jordi a Santa Jordina, una curiosità catalana

È una delle mie feste preferite, e ci siamo quasi. Il 23 aprile tutta la Catalogna celebra Sant Jordi, patrono della regione, in una festa che nel corso dei decenni è diventata anche rivendicazione della cultura catalana. Da Barcellona ai più piccoli paeselli della Catalogna, le strade si riempiono di banchetti di libri e di rose rosse, simboli della festa.
Sant Jordi (in italiano San Giorgio) era un soldato romano che abbracciò la fede cristiana e, per questo, nel 303 l'imperatore Diocleziano lo fece martirizzare.
La celebrazione catalana, però, si basa su una leggenda popolare del XIII secolo contenuta nella Legenda Aurea, la raccolta di biografie di santi scritta da Jacopo da Varazze nel 1298.
La leggenda catalana si svolge nel paesello di Montblanc. I fatti ricordano quelli della Legenda Aurea: un villaggio è vessato dalle ire di un terribile drago che gli abitanti tengono a bada dandogli in pasto il bestiame. Quando non rimangono più animali da offrire al drago, gli abitanti decidono di estrarre ogni giorno a sorte una ragazza del villaggio e sacrificarla. La tragedia va avanti fino a che non arriva il turno della figlia del re. E qui, eccolo, il colpo di scena: mentre la principessa va incontro alla sua sorte, compare un cavaliere in un’armatura bianca che affronta il drago e riesce a ucciderlo. Il sangue del drago, toccando terra, si trasforma in un magnifico rosaio. Il cavaliere coglie una rosa e la offre alla principessa prima di dileguarsi all’orizzonte. 🌹
Da qualche anno, però, Sant Jordi, il cavaliere leggendario che salva la principessa dal drago, non è più il solo a essere festeggiato: è infatti sempre più frequente sentir parlare anche di Santa Jordina (o Georgina), il suo corrispettivo femminile.
Dopo secoli di narrazione secondo cui sono le donne a esser salvate dal prode cavaliere, la leggenda popolare catalana si presta a cambi di prospettiva e accoglie Jordina, colei che, con cappa e spada, fronteggia il drago senza paura:

Per questa settimana ho finito, ci sentiamo tra due lunedì.
Vuoi lasciarmi un'opinione, una richiesta di contenuti futuri o di collaborazione? Scrivimi senza problemi, ti basta rispondere a questa email.
Ojalá è una newsletter gratuita e lo rimarrà sempre. Se leggi ogni numero, usi per lavoro le risorse che consiglio e puoi permetterti di farlo, supporta il mio lavoro:




Grazie, Alice <3
Quante cose abbiamo ancora da imparare