#55 Siamo nomi, case, lingue.
Le parole liberano ma creano anche scatole, finché non ne troviamo di nuove.

Ho iniziato gennaio con un corso monografico sul concetto di casa.
Cos’è casa, per te?, ci siamo chieste. Cosa vuol dire sentirsi a casa?
E famiglia, cosa significa? Soprattutto per persone simili a me — adulte tra i trenta e i quaranta, magari senza figli, emigrate; noi che abbiamo una rete di persone care che si estende geograficamente tra più Paesi e un’altra rete più piccola e vicina, costruita con gesti e attenzioni quotidiane. Una rete che dà vita a qualcosa senza un nome da dizionario, un nome che la distingua da altri costrutti sociali che invece sì, hanno un appellativo e un riconoscimento comune.
Per me casa, in questo mio quarantunesimo anno di vita, è un divano-letto aperto in sala da pranzo. Aperto per chi non vive qui ma arriva e finisce per passarci la notte; aperto per chi ci viene a trovare da lontano; aperto per le serate di cibo da asporto e film; aperto per le conversazioni pigre che durano ore e per quelle più complicate che durano minuti ma sembrano non finire mai.
Sul divano-letto aperto, da cui — come al solito — scrivo anche questo episodio di Ojalá, mi sento a casa e mi metto in discussione, perché è quello che sono abituata a fare, anche quando sto comoda. Mettermi in discussione è una delle cose che ho imparato a fare a casa.
Ti va di dirmi cos’è casa per te?
Quando siamo in discussione, ci mettiamo in discussione *
Mentre cercavo materiale per il corso, ho ritrovato il blog di Sara Ahmed, ricercatrice e scrittrice britannico-australiana che si muove tra studi femministi, queer e razziali. Nel 2016, Ahmed ha lasciato la ricerca universitaria e si è licenziata dalla Goldsmiths University di Londra per protestare contro la gestione di alcuni casi di molestie sessuali all’interno dell’università.
Nel suo storico blog chiamato “Feminist Killjoys” (femministe guastafeste) c’è un articolo del 2014 che dice (e che traduco dall’inglese, aggiungendo anche un grassetto):
Sto camminando per strada a Cardiff. Un uomo che cammina nella direzione opposta alla mia si ferma. Sembra interessato a me.
A cosa sono, a se sono qualcosa?"Ehi, di dove sei?"
La domanda è posta con una curiosità sorridente. È una domanda familiare, ma è una domanda scomoda. So cosa mi sta chiedendo davvero. Resisto a dare la risposta che mi viene richiesta.
"Australia", dico.
”No, voglio dire le tue origini”, dice lui.
"Sono nata a Salford".Il volto dell'interrogante si piega per l'irritazione.
"Di dove sono i tuoi genitori, allora?"
Sa che so cosa mi sta chiedendo.
Mi arrendo, ho voglia di proseguire."Mio padre viene dal Pakistan".
È tutto. La conversazione è finita. Ho dato la risposta giusta. Ho spiegato da dove vengo, ho raccontato di non essere di qui, di come sono finita ad avere la pelle marrone.
[…]
Venir interrogatə, essere fonte di dubbio, a volte può sembrare una residenza: una domanda diventa qualcosa in cui si risiede.
Risiedere in una domanda può farci sentire di non risiedere nel luogo in cui ci troviamo.
Non sei di qui, no? O forse diventare un “non” è come essere avvoltə da un'affermazione.
Coloro il cui essere è messo in discussione, sono coloro che mettono in discussione l'essere *
Per molti anni, dopo essere emigrata dalla Sardegna nel 2004, ho avuto la sensazione di star perdendo la possibilità di sentirmi parte di un luogo preciso.
Mi sentivo sarda, ma a volte quando tornavo in Sardegna mi chiamavano “la continentale”. Vivevo a Siena, a Milano, e poi a Pavia, a Genova, a Strasburgo, a Barcellona, e lì potevo essere “la sarda”, “l’isolana”, “l’italiana”, “la guiri”, “messican o cilena? Hai un accento strano”.
Ora ho smesso di chiedermelo, credo. Non cerco più di aggrapparmi a un luogo. Ho un’isola e un paesello di provenienza, dove risiedono i miei affetti più antichi; ho un Paese di crescita, dove si è formata parte della mia identità; ho diversi luoghi di passaggio, dove ho visto fiorire amicizie e lasciato ricordi; ho un Paese di arrivo: quello in cui ho cambiato vita, imparato due nuove lingue, comprato casa, riempito la mente di nuove prospettive. Ho un Paese di arrivo da cui non mi immagino andare via ma di cui non farò mai parte fino al midollo.
Nel paesello catalano in cui vivo, per esempio, ho sempre avuto chiaro il fatto di “non essere di qui”. Sono diventata visibile nel momento in cui abbiamo adottato Uras, la nostra cagnetta, due anni dopo il trasferimento.
I cani possono socializzare al di fuori delle parole e degli accenti.
Uras, per esempio, si siede dritta in mezzo alla strada, la coda scondinzolante che spazza l’asfalto e gli occhioni verdi fissi sulla persona che cammina verso di lei; con questo suo linguaggio non verbale riesce a parlare con chiunque abbia voglia di avvicinarsi.
Lei dà per scontata la comunicazione e il ricordo reciproci. ”Ti ricordi di me? Mi hai accarezzata una volta, è ovvio che vorrai farlo di nuovo, no?”
Io pochi mesi fa ho gioito perché finalmente, nel bar in cui faccio colazione da tre anni, Mari mi ha chiesto “cafe con leche e bocadillo de queso, ¿verdad?”.
Mari, la persona che si è ricordata dei miei gusti, lavora qui da poco e anche lei viene da fuori, come me.
Eppure è bastata quella frase, quel lampo di familiarità, a farmi fare un passo in più nel sentirmi a casa qui.
Negli anni mi sono chiesta spesso di dove sono, ora che sono via dalla mia casa di nascita da più di due decenni. C’è un punto di vista che ho sentito spesso condividere da altre persone emigrate come me; è la sensazione di “non essere abbastanza di qui” ma nemmeno “troppo di qui”, la stessa che descrive — seppur partendo da diverse condizioni migratorie — Brigitte Vasallo in questo passaggio del saggio Per una rivoluzione degli affetti. Pensiero monogamo e terrore poliamoroso (effequ, 2022):
Scrivo di nazione monogama da una Catalogna con aneliti d’indipendenza dallo Stato spagnolo e con una Spagna in agguato, disposta a perseverare in un’unità istrionica in cui non crede quasi più nessuna. Scrivo a partire da un’identità charnega, sospetta da ciascun lato di questa storia e sotto costante sorveglianza. Essere charnega significa, secondo il Dizionario della Real Academia de la Lengua Española, “immigrata in Catalogna da una regione spagnola di lingua non catalana”. E si tratta di, chiarisce il dizionario, un termine dispregiativo. Ed ereditario, aggiungo io.
L’essere charnega non ha tanto a che fare con l’origine geografica, ma con questa origine attraversata dal ceto sociale. Non importa tanto da dove viene la tua famiglia, ma come è venuta e perché. Essere charnega, poi, significa tante cose che hanno a che fare con la classe, con la miseria originaria e con la bastardaggine, il confine, l’impurità.
E significa anche che non sei abbastanza... o che sei troppo. Nel mio caso, né abbastanza gallega in Galizia, né abbastanza catalana in Catalogna. O, visto da un’altra prospettiva, troppo catalana in Galizia e troppo gallega in Catalogna, un eccesso difettoso o un difetto eccessivo che mi riempie di gioia – perché dovrei mentirvi? Le lingue che porto con me alla base sono il catalano e il castigliano. La mia lingua relazionale è multipla e include l’arabo e l’inglese. Non so cosa significhi ‘lingua madre’. La mia madre naturale mi parlava in un gallego castiglianizzato, la mia madre scelta mi parla in un arabo marocchinizzato, io parlo a mio figlio in catalano barcellonese.
La lingua materna è quella che mi è stata trasmessa o quella che trasmetto io?
Ti lascio questa domanda sospesa.
* I titoli dei paragrafi che hai letto fin qui sono la traduzione di due frasi trovate nel blog di Sara Ahmed.
“Tengo nombre”: un progetto antirazzista barcellonese
Da qualche settimana, a Barcellona e sui social girano manifesti come questi:
Si tratta della campagna #TengoNombre (@tengonombre_ su Instagram) lanciata per denunciare quelle microaggressioni che negano un nome proprio alle persone razzializzate che lavorano in bar, minimarket, negozi di telefoni o di articoli per la casa. Quelle attività che anche in italiano vengono appellate in base alla nazionalità della persona che ci lavora: “il cinese”, “il bar di cinesi”, “il pakistano”, ecc.
Dice Su Dang Lu, proprietaria del bar 104 nel quartiere Poblenou di Barcellona:
Un gesto semplice come chiedere il nome o riferirsi a questi locali semplicemente come bar, tasca, colmado o supermercato fa una grande differenza per persone come Dang. "È molto offensivo essere chiamati 'cinesi'. E non parlo nemmeno di 'chinito'", dice riferendosi ai suoi figli, che frequentano una scuola del quartiere. "Tutti i miei connazionali dicono ai loro bambini di non farci caso e di non rispondere, perché non vogliamo problemi", spiega.
Ma grazie al cartello rosso sulla porta del suo bar, ha cambiato idea. Ora incoraggia i suoi figli a lamentarsi. Così come sta iniziando a rimproverare i clienti che la chiamano "la cinese". "Un conto è se mi chiamano così in modo affettuoso, come io chiamo Miguel, il proprietario del bar accanto, 'galiziano'. Perché lui è orgoglioso di essere galiziano, così come io sono orgogliosa di essere cinese, ma non chiamatemi così solo perché non vi interessa come mi chiamo. Sono una persona e ho un nome", afferma.
Che dici, potrebbe funzionare anche in Italia?
Per questa settimana chiudo qui.
Vuoi scrivermi cosa ne pensi di questa newsletter, propormi una collaborazione o semplicemente mandarmi un saluto?
Fallo: rispondi a questa email o scrivimi su ojala [at] aliceorru.me 📧
Se ormai conosci Ojalá e apprezzi il mio lavoro, dai un’occhiata al piano a pagamento: con meno di 4 euro al mese puoi supportare questo progetto.
Ok, è davvero tutto.
Grazie per aver letto fino a qui. 💙
Alice




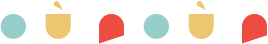
![Un manifesto viola con scritta bianca che dice: "Non sono “il paki di sotto”. Mi puoi chiamare [spazio bianco] o anche: programmatore, informatico, tecnico. #TengoNombre" Un manifesto viola con scritta bianca che dice: "Non sono “il paki di sotto”. Mi puoi chiamare [spazio bianco] o anche: programmatore, informatico, tecnico. #TengoNombre"](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!yVSb!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F8f626c16-702c-48a3-bcf2-42b6201ca1ec_596x843.png)
![Manifesto verde con scritta bianca che dice: "Non sono “il cinese”. Mi puoi chiamare [spazio bianco] o anche: bazar, negozio di alimentari, bottega. #TengoNombre" Manifesto verde con scritta bianca che dice: "Non sono “il cinese”. Mi puoi chiamare [spazio bianco] o anche: bazar, negozio di alimentari, bottega. #TengoNombre"](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!1p7v!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F7f7a7e1c-0f6b-41e6-a328-8806b18ac206_596x842.png)

Casa per me è sentirmi a casa, non è solo un luogo geografico definito da coordinate spaziali.
Casa è presso di me, nello sguardo di mia figlia, nell'abbraccio della mia compagna.
Alle volte è sul divano, nel posto in cui mi piace sedermi e rilassarmi.
Casa è dove sono di casa, dove abito e ho abitudini, dove mi sento libero. Casa è dove tornare.
È sopra di un palco, quando faccio improvvisazione teatrale.
È nelle idee e nelle azioni condivise, in un sorriso, nelle lacrime e nella gentilezza.
Casa è un posto segreto dentro al cuore di cui poche persone posseggono le chiavi.