#97 Fuori norma
L'illusione dello spazio neutro, la possibilità di passare inosservata. Riflessioni tra la giornata di sensibilizzazione sull’accessibilità e quella contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.
L’ultimo numero di Ojalá parlava di cittadinanza finanziaria e conteneva una demo di email da mandare a chi gestisce il tuo fondo pensione, se ne hai uno.
In questo episodio:
Sono una che passa inosservata, anche perché gli spazi in cui mi muovo quotidianamente sono pensati prevedendo persone come me.
Ho ascoltato Ilaria Crippi sfatare il mito della norma e ricordare che lo spazio non è neutro. Mai.
Ha anche spiegato molto bene l’oggettività del concetto di abilismo.
E poi: il progetto fotografico crip-queer Metáfora Project; la bellissima guida di ICOM sulla cultura trans-positiva e accessibile nelle istituzioni culturali; due episodi di newsletter sugli spazi emotivi mai neutri e le cose che non si vedono:
e .

Sono una persona che ha la possibilità di passare inosservata o, per usare l’originale parola inglese che definisce precisamente il concetto, può contare su una buona dose di passing.
Passing è il termine che definisce la possibilità, spesso involontaria, di essere percepita come una persona "nella norma", cioè in linea con ciò che la società si aspetta in termini di genere, orientamento, abilità, e altri aspetti dell’identità.
Quando cammino per strada in una qualsiasi città sono una donna cis con un’espressione di genere femminile, senza disabilità visibili; se sono in giro con il mio compagno, vengo letta come donna etero.
Ho dalla mia una serie di caratteristiche fisiche ed estetiche che mi inseriscono al volo nel cassetto “persona nella norma”. È una protezione sottile ma potente che mi tiene al riparo da sguardi e domande indiscreti e — soprattutto alla luce del giorno — da determinati pericoli. Sono “leggibile”, accettabile, socialmente ok.
Per essere riconosciuta come persona fuori dalla norma, potrei fare alcune scelte comunicative o decidere attivamente di esplicitare aspetti di me che non sono visibili. La scelta, però, è quasi del tutto in mano mia: dipende per esempio da come decido di raccontarmi, come voglio comportarmi con le persone con cui mi accompagno, quali discorsi preferisco fare quando sono in spazi pubblici. Per il resto, passing.
E non è solo una questione di come vengo percepita: è anche una questione di quali corpi e identità il mondo intorno a me si aspetta di incontrare.
Ho la possibilità di passare inosservata anche perché, nella maggior parte dei casi, gli spazi in cui mi muovo quotidianamente prevedono persone come me. Che camminano sulle loro gambe, che non hanno problemi a interpretare cognitivamente e visivamente le indicazioni stradali. Che possono entrare senza indugi nel bagno delle donne e, in ambienti che considerano particolarmente sicuri, usare il bagno degli uomini se è libero e la fila femminile lunga. Persone che non hanno bisogno di assistenza per volare in aereo né devono spendere un extra per comprare un sedile più largo (sempre che la compagnia aerea lo preveda). Che non hanno bisogno di giustificare fatti privati della loro vita per sentirsi incluse dal sistema e dalla sua burocrazia o godere automaticamente di certi diritti civili.
Qualche giorno fa ho ascoltato Ilaria Crippi presentare dal vivo il suo bellissimo libro Lo spazio non è neutro, un saggio che consiglio sempre a chiunque voglia capire cosa significa abilismo e cosa implica attivarsi per ottenere spazi più accessibili.
Se è abbastanza immediato comprendere l’effetto materiale di una barriera (escluderti dalla fruizione di un contesto), i suoi effetti psicoemotivi restano troppo spesso invisibili.
Eppure un luogo o un servizio non accessibili, oltre a causare un’esclusione materiale, trasmettono potenti significati: dicono qualcosa riguardo a chi appartiene e chi non appartiene a quel contesto; ci ricordano che siamo «fuori posto», diverse, non previste. Ricevere questo costante promemoria dall’ambiente attorno a noi produce effetti emotivi oltre che pratici e può incidere sul nostro benessere psicologico.
— Ilaria Crippi, Lo spazio non è neutro, Tamu_Edizioni (pp. 98-99).
Gli spazi che abitiamo — siano essi fisici, sociali, culturali — non sono mai neutri, cioè progettati in modo imparziale o universale: riflettono e perpetuano strutture di potere e norme sociali che favoriscono determinati corpi e identità a discapito di altri.
Ne avevo parlato anche tempo fa, affascinata dalla teoria di città femminista di Leslie Kern:
Parlare di accessibilità oggi, quindi, non implica solo puntare i riflettori sulle barriere architettoniche che costellano i nostri spazi, ma imparare a vedere anche tutti gli altri aspetti della vita in cui l’accessibilità fa la differenza: la possibilità di essere persone libere di muoversi, di andare a vivere da sole, di studiare senza intoppi, di conoscere persone in un bar, di formare una famiglia o divorziare, di uscire da sole, di fare controlli medici senza sentirsi giudicate o ignorate… Tutte le libertà che si danno per scontate perché considerate “normali” e inserite nel pacchetto diritti di default; ed è con quel prezioso pacchetto che tantissime persone si muovono nel mondo.
E allora perché non ci sembra scandaloso e inconcepibile che certe altre, invece, non possano disporre di quello stesso pacchetto di diritti e libertà? Perché l’accessibilità è trattata per lo più come una rogna burocratica da rispettare, “da mettere a norma”, e non come un pensiero primario alla base di ogni progettazione?
Abilista, realtà più che insulto
Nella comunicazione mainstream, l’aggettivo abilista ha acquisito una connotazione negativa, una parola che si può usare come accusa: “sei abilista” è diventata la versione breve di “discrimini le persone con disabilità”.
Eppure, di per sé, la parola abilismo nasce per descrivere una situazione oggettiva: un sistema sociale e culturale che privilegia le persone considerate "abili", marginalizzando chi non rientra in quella norma.
Secondo i Disability Studies, l'abilismo è una forma di oppressione sistemica, al pari di razzismo, omobitransfobia o sessismo, che si manifesta a tutti i livelli della società. In questa prospettiva, la disabilità non è un difetto individuale, ma il risultato di barriere sociali, culturali e fisiche create da una società che presume la "normalità" dell'abilità e, di conseguenza, disabilita le persone che non rientrano in quella norma.
Da qui la forza di un’espressione come persone disabilitate, anziché disabili. Come scriveva l’anno scorso Iacopo Melio su Invalidità e Diritti:
Partiamo dal presupposto che le uniche due definizioni corrette sono “persona con disabilità” (person first) oppure “persona disabile” (identity first). Entrambe sono appunto valide, ma deve essere la persona interessata a scegliere con quale dei due “metodi” vuole essere definita, in base a se preferisce porre l’accento sul suo essere “una persona” (e quindi rendere la disabilità una caratteristica generica, in mezzo a tutte le altre) o sulla sua identità (rafforzando quindi il concetto di “essere” disabile, rivendicando la propria condizione).
Premesso questo, c’è un aspetto ancor più utile e importante che sta in una terza definizione che è quella di persona ”disabilitata”: questa scelta, che può sembrare sicuramente inusuale ma, se diventasse comune, porterebbe senz’altro a una maggiore presa di coscienza collettiva, serve a sottolineare il fatto che la disabilità non è strettamente legata alla persona in questione, né tantomeno è una sua responsabilità, bensì che è la società a creare una precisa difficoltà, e quindi a “disabilitare” le cittadine e i cittadini, quando non fornisce loro gli strumenti, i servizi e gli aiuti necessari per poter vivere sempre in piena autonomia e indipendenza.
In questo contesto, definire un comportamento, un'istituzione o un sistema come "abilista" serve a evidenziare le strutture che escludono o discriminano le persone con disabilità, non tanto per attribuire colpe individuali ma per sottolineare un problema di pensiero collettivo.
Per approfondire ancora il tema, un’altra bella lettura da fare è il libro Mezze persone. Riconoscere e comprendere l'abilismo di Elena e Maria Chiara Paolini.
Ho scritto questo numero di Ojalá sulla scia dei pensieri che hanno unito la celebrazione di due giornate internazionali che mi stanno molto a cuore: la Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’accessibilità (il 15 maggio) e la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (il 17 maggio).
Non sono un’amante delle giornate internazionali da celebrare, soprattutto in un’epoca in cui diventano un’ottima scusa per riempire i piani editoriali sui social. Anche perché, come scriveva il mese scorso
nella sua Scienziolitica dedicata alle “giornate internazionali”,durante le giornate internazionali cerchiamo effettivamente più informazioni sul tema, ma a meno di non ricevere interventi dedicati a una sotto-categoria professionale o identitaria a cui apparteniamo non tratteniamo granché di queste informazioni, né tantomeno cambiamo i nostri comportamenti.
Eppure a me, che di accessibilità e diritti LGBTQIA+ mi occupo ogni mese dell’anno, queste due giornate internazionali così ravvicinate aiutano a pensare alla connessione tra le discriminazioni. E a quanto sia limitante pensarle come silos non comunicanti.
Mi ricordano, semmai ce ne fosse bisogno, che lo spazio non è neutro, non lo è mai. Pensare che esista un default reale, qualcosa che possa considerarsi una ‘situazione neutra di partenza’, è un’illusione. Una di quelle che fanno male, quando si rompono.
Perché chiunque di noi — anche senza volerlo, anche solo invecchiando — si troverà prima o poi fuori dalla norma.
Mentre scrivevo, avevo chiarissimo che avrei illustrato questo episodio con una delle opere del Metáfora Project, progetto fotografico partecipativo esposto fino a giugno al Centre LGTBI di Barcellona.
Sei corporeità dissidenti. Un'alleanza crip-queer. Sei fantasie.
— dice la presentazione nel sito dell’organizzazione SIDA STUDI.
Metáfora Project è una mostra per rappresentare il desiderio e il piacere dal punto di vista della diversità funzionale, una messa in discussione critica della sessualità normativa e dell’abilismo dal punto di vista erotico. Un contro-immaginario del desiderio senza limiti.
⏸️ Se apprezzi il mio lavoro e leggi con interesse Ojalá, hai mai pensato di sostenerla economicamente? Con 40 euro sostieni questo progetto per dodici mesi: in cambio hai accesso all’archivio completo degli episodi e alla mia biblioteca digitale con le risorse che alimentano questo progetto.
Letture per continuare a esplorare
Ti consiglio di dare un’occhiata alla nuova guida Musei e Generi. Etica, metodi e approcci per promuovere una cultura trans-positiva e accessibile nelle istituzioni culturali, pubblicata poche settimane fa da ICOM Italia. Curata dal Gruppo di Lavoro Genere e Diritti LGBTQ+ di ICOM Italia, la guida contiene strumenti pratici per rendere i musei spazi più inclusivi per le persone trans e non binarie: è una lettura coinvolgente e utile anche se non lavori in ambito museale.
Quanto costa un’ora d’aria di Simone Riflesso, che nella sua bio su Substack si definisce “Disabile incattivito in cattività”: un racconto intenso e amaro sul prezzo emotivo da pagare per poter godere di un momento di leggerezza.
Di passing e ferite invisibili ha scritto Paola Chiara Masuzzo, che da poco è tornata a lavoro dopo il cancro: Le cose che non si vedono.
Un ripasso: l’articolo che ho scritto l’anno scorso per ValoreD in occasione del 17 maggio, su come smascherare l’eteronormatività e le sue conseguenze.
Il decreto Elezioni, passato di recente, finalmente elimina il cognome del marito per tutte le donne sposate o vedove e la distinzione per genere nelle liste elettorali. Questa novità, però, non sarà già valida ai referendum dell’8-9 giugno: questo articolo di Pagella Politica spiega che la sua effettiva applicazione presenta almeno due problemi.
Come suonerebbe questo episodio di Ojalá?
Tutta la musica che consiglio su Ojalá atterra su questa playlist collaborativa su Spotify. Che canzone assoceresti a questo episodio? Scrivimelo via email o nei commenti di Substack. 🎶
Per questa settimana chiudo qui.
Vuoi scrivermi cosa ne pensi di questa newsletter, propormi una collaborazione o semplicemente mandarmi un saluto?
Rispondi a questa email o scrivimi su ojala [at] aliceorru.me 📧
Sono Alice Orrù, sarda emigrata a Barcellona nel 2012.
Fiera della sua residenza, la mia newsletter contiene incursioni di vita catalana e tanta, tanta salsa brava. 🍟
Se ormai conosci Ojalá e apprezzi il mio lavoro, dai un’occhiata al piano a pagamento: con 40 euro sostieni questo progetto per un anno intero e hai accesso a tutte le risorse originali, passate e presenti, che condivido.
Grazie per aver letto fino a qui. 💙
Alice




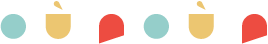
Grazie Alice per questa riflessione. Voglio dare il mio contributo, da persona generalmente "passing" per la definizione che hai dato tu, ma che per un periodo ha vissuto da "disabilitata" per un motivo sciocco che merita una riflessione.
Per motivi che non so (lockdown? menopausa? noia?) tra il 2020 e il 2024 il mio peso è aumentato di 20 kg, da 50 a 70 per capire le proporzioni.
Mi sono ritrovata non solo appesantita, ma con una prominenza visibile sull'addome.
Ho più di 50 anni, porto i capelli grigi per scelta, e non credo di essere particolarmente giovanile, ma nonostante questo ho trovato infinite persone che mi hanno fatto i complimenti per il bimbo in arrivo, quando non mi hanno posato direttamente la mano sulla pancia. Conoscenti sì, ma anche perfettз sconosciutз. Rabbia, disagio e vergogna da parte mia.
Nei negozi di abbigliamento venivo guardata con sufficienza, perché non c'era nulla che mi si allacciasse sul davanti, mentre le mie spalle e il mio seno erano rimasti minuti.
Il mio corpo era diventato non più conforme; anzi, proprietà di chiunque mi incontrasse e esposto al giudizio.
Per questo sono d'accordo sulla tua ultima riflessione: il problema della disabilitazione dei corpi e delle identità riguarda tuttз, ed è doveroso creare sensibilità su questi temi. Non solo perché potrebbe toccare anche a noi, ma perché è ingiusto che una persona provi disagio per com'è.
(Finale: mi sono messa a dieta controvoglia, ho ripreso una forma socialmente accettabile. Ho rinunciato a una quantità di cose dolci e piacevoli, fra cui la fiducia incondizionata verso le persone.)
Alice mi sa che non ti leggevo al tempo di Ojalá n. 44, perché leggendo i primi paragrafi mi era venuto subito in mente Feminist City (un libro che ho trovato illuminante). E subito dopo ho visto che ne avevi già parlato! Great minds...(scherzo ahaha).
Interessante la riflessione sulle giornate internazionali. Io tendo a evitare qualsiasi contenuto che sappia anche lontanamente di "giornata internazionale" perché ci trovo spesso troppa retorica e perché, come dici tu, sembrano spesso silos isolati.
Per qualche anno ho partecipato attivamente agli eventi in occasione della HG awareness day, la giornata per la consapevolezza dell'iperemesi gravidica (mi sa solo americana), di cui ho sofferto. Poi ho fatto un passo indietro perché mi sembrava che in quella giornata ce la suonassimo e cantassimo da sole, e quelle che effettivamente ottenevano risultati erano le persone che portavano avanti attività di sensibilizzazione per tutto l'anno (di lavoro). Dall'altro lato, c'è spazio anche per chi come me non può offrire un sostegno professionale, organizzato e sostenuto nel tempo, ma si sente vicina alla causa per vari motivi (?). E immagino che sia sia così per tutte le altre cause.
Insomma non ho un pensiero compiuto al riguardo, solo una domanda aperta su come utilizzare queste occasioni in modo sensato e produttivo (che non sia un post social pieno di retorica). Ora corro a leggermi la puntata di Eleonora Marocchini!