#103 Parlarne tra amiche
Medicina di genere, linguaggio medico e pregiudizi sulla salute sessuale: la terna che invisibilizza le donne queer.
L’ultimo numero di Ojalá si preparava all’accessibility armageddon e all’epoca dei Pride, soprattutto critici. Quello prima era invece perso in uno scrolling senza senso tra peluche in technicolor e orrori quotidiani.
In questo episodio:
Si parla molto di sesso, ma non nel modo che forse immagini.
Quando la medicina è impregnata di pregiudizi sulle persone LGBTQIA+: due indagini e un articolo che descrivono bene il panorama in cui ci muoviamo.
Ho parlato con otto amiche saffiche di linguaggio discriminatorio, pregiudizi e sorprese durante le visite ginecologiche.
Una campagna di prevenzione svizzera, letture gioiose e newsletter per approfondire.

Quando Claudia ha fatto la prima visita con la dottoressa Z., la ginecologa che riceve nel paese vicino al mio e che le avevo raccomandato, è tornata entusiasta:
È la prima volta che una ginecologa mi visita in modo completo senza farmi domande imbarazzanti o fuoriluogo, non ero abituata!
Che interazione avrà mai avuto Claudia con la ginecologa per generare tanto entusiasmo? (Oltre al fatto che la nostra dottoressa è proprio brava, in effetti.)
Se hai avuto esperienza con le visite ginecologiche, forse potresti azzardare qualche ipotesi: magari anche a te è capitato di ricevere commenti inopportuni sulle tue abitudini sessuali, sui tuoi progetti di (non) procreazione o sul livello di dolore sopportabile durante le mestruazioni.
Prima di darti conferma, ti do un altro dettaglio: Claudia è lesbica.
Questa informazione potrebbe suggerirti poche piste oppure, soprattutto se sei una persona queer o ne frequenti, sai che non è un dettaglio da poco. E infatti Claudia mi aveva riassunto così la sua esperienza “tipo” negli studi ginecologici:
Sono abituata al fatto che durante l'anamnesi si dia spesso per scontato l'orientamento eterosessuale. Dopo la prima domanda di protocollo "Sei sessualmente attiva?", il personale medico passa direttamente a chiedermi che metodo contraccettivo uso, dando per scontato che la mia attività sessuale equivalga a rapporti eterosessuali.
Non è l’unica donna saffica con cui ho avuto una conversazione simile. Le difficoltà che le donne saffiche e le persone queer in generale sperimentano durante le visite ginecologiche sono tema delle conversazioni informali tra amiche ma anche di alcune ricerche, soprattutto internazionali.
I manuali per formarsi non mancano
Prima del 2007, le ricerche italiane sulla salute sessuale delle persone LGB — all’epoca le lettere TQIAP non si prevedevano nemmeno, a livello istituzionale — erano poche, spesso frutto di iniziative locali o di studi qualitativi pionieristici guidati da associazioni.
La prima indagine italiana risale al 2006, promossa da Arcigay e Arcilesbica e finanziata dal Ministero della Sanità. Si intitolava "MODI DI" e raccoglieva interviste alle persone LGB per indagare sulle loro condizioni di salute e anche sui rapporti con il personale medico.
Nel 2007 (sì, solo nel 2007…) viene pubblicata dalla Regione Toscana una delle prime indagini sistematiche italiane sugli atteggiamenti del personale sanitario verso la popolazione LGBT: Pazienti non previsti in Ospedale. Atteggiamento del personale sanitario, verso la popolazione lesbica, gay, bisessuale e transessuale (il link apre direttamente il pdf).
Questa indagine — che, visti i tempi, aveva un’impostazione piuttosto binaria — si concentrava sulle conoscenze, le percezioni e i comportamenti del personale sanitario. Non ti faccio nessuno spoiler, immagino, se ti dico che i risultati evidenziavano gravi lacune sulla salute delle persone omosessuali, che veniva spesso trascurata, sottovalutata o affrontata con pregiudizi e imbarazzo, anche nelle strutture ginecologiche. Giusto per citarti un dato, che riprendo dal documento:
La quasi totalità del campione (91,3%) non ritiene opportuno chiedere l’orientamento sessuale ai propri pazienti, in quanto “non rilevante ai fini diagnostici assistenziali” o “per rispetto della cosiddetta privacy”, vanificando così l’opportunità di prendersi cura della persona nella sua globalità e non solo della parte malata o temporaneamente invalidata.
Non saprei dire come è evoluto quel dato, diciotto anni dopo; di certo oggi esistono più strumenti, corsi e linee guida che promuovono una sanità inclusiva e formano il personale sanitario sulle esigenze delle persone LGBTQIA+.
Sono molto complete, per esempio, le linee guida A porte aperte! Un manuale LGBTI per professionisti sanitari (link diretto al pdf), frutto del progetto Open Doors: Promoting Inclusive And Competent Health Care For LGBTI People:
L’iniziativa A porta aperte! è stata attiva dal 2019 al 2022, finanziata dal programma europeo Rights, Equality and Citizenship Programme, e ha coinvolto diversi partner europei, tra cui l’Università degli Studi di Brescia. L’obiettivo era promuovere cure sanitarie più inclusive e competenti per le persone LGBTQIA+.
Di linee guida simili se ne trovano sempre di più, ma la realtà delle persone LGBTQIA+ alle prese con il personale sanitario è ancora impregnata di pregiudizi e brutte esperienze.
La conversazioni tra amiche (e non solo) dicono altro
Questo numero di Ojalá era in cantiere da diverso tempo e in realtà potrebbe essere il primo di una serie, viste le sfaccettature che il tema ingloba.
La spinta per scriverlo in modo più strutturato, però, è arrivata qualche settimana fa, quando ho letto questo articolo di Cristina Da Rold per il blog di AIRC: Le persone LGBTQ+ sono più colpite dal cancro. Perché e cosa possiamo fare?
Ti riporto due dei passaggi che mi hanno colpita di più:
Ci si è resi conto che le persone che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali o non conformi al genere (LGBTQIA+) affrontano spesso discriminazioni e stress da minoranza, che potrebbero contribuire a un aumento del rischio sia dello sviluppo di un tumore sia della mortalità per cancro.
[…] è emerso che le persone della comunità LGBTQI+ partecipano meno alle campagne di screening oncologici e di vaccinazione, spesso a causa del timore di essere discriminate, dal momento che in alcuni casi sono previste visite che riguardano gli organi genitali e la sfera sessuale.
Ho immeditamente pensato alle esperienze di cui è capitato di parlare con amiche lesbiche, pansessuali e bisessuali: è ancora troppo comune incontrare personale medico in ginecologia che non rende le visite di controllo sufficientemente accessibili per le donne cis non etero.
Lo sappiamo, ne discutiamo, ma è raro che il tema buchi la nostra bolla. Per questo ho voluto coinvolgere alcune donne saffiche della mia vita per fare mente locale e puntare il riflettore su quelle storture comunicative che fanno sentire più giudicate, incomprese o ignorate durante le visite ginecologiche.
Otto testimonianze saffiche
Ho chiesto a otto amiche di parlarmi del loro rapporto con la prevenzione ginecologica e delle loro esperienze — soprattutto linguistiche — con il personale medico.
Sono donne che vivono in Italia e in Catalogna, hanno un’età che va dai 28 ai 49 anni e coprono una buona parte dello spettro saffico: cinque sono lesbiche, una è pansessuale, due sono bisessuali.
Questa conversazione, naturalmente, non ha nulla di scientifico ma ci tenevo a raccogliere testimonianze di persone a me vicine. Credo molto nel potere delle testimonianze dirette per sensibilizzare, aprire un dialogo e migliorare la consapevolezza sulle sfaccettature della salute con prospettiva di genere.
Prima di proseguire, ringrazio infinitamente Agnese, Chiara, Claudia, Elena, Francesca, Linda, Marta e Roberta per il tempo che mi hanno dedicato e per aver contribuito a questo numero di Ojalá. ❤️
L’eterosessualità data per scontata
Quasi tutte le amiche hanno raccontato esperienze simili a quella di Claudia con la supposizione di eterosessualità. Francesca ha ricordato di quando un medico le chiese informazioni sul suo ultimo rapporto sessuale, dando per scontato che fosse di natura penetrativa e con un uomo. Aveva dovuto chiarire che la sua partner sessuale era una donna e che individuare il suo ultimo rapporto sessuale non equivaleva al suo ultimo rapporto penetrativo.
Tutte e otto mi hanno detto di aver incontrato almeno una volta ginecologhə che hanno fatto la stessa supposizione. Linda, dopo il primo episodio, ha cambiato direttamente ambulatorio. Elena ha fatto l’esempio delle istruzioni ricevute prima di un esame ginecologico, quel generico "non avere rapporti sessuali per 24 ore”.
Cosa significa “avere rapporti sessuali” nel contesto di raccomandazioni mediche da seguire prima di un esame? Di quale tipo di rapporti si tratta? Penetrativi? O qualsiasi tipo di contatto sessuale?
In questi casi, è comune assumere che si parli di rapporti penetrativi eterosessuali.
Quello che manca per rendere le istruzioni più chiare e inclusive è il perché. Qual è la ragione per cui è consigliata l’astensione prima dell’esame? Saperlo permetterebbe a chiunque, di qualsiasi genere e orientamento, di adattare con consapevolezza le proprie abitudini sessuali alle raccomandazioni mediche.
Sia Chiara che Agnese mi hanno raccontato di tutte le volte in cui il medico ha chiesto se usassero il preservativo, sottintendendo, come spesso accade, che si trattasse di quello maschile. (Esistono anche i preservativi orali o oral dam, ma quanto poco se ne parla?).
Roberta invece mi ha ricordato quanto incidono l’eteropassing — nel suo caso, avere un’espressione di genere molto femminile che «esclude l’opzione lesbica dal minuto uno» — e gli immaginari stereotipati; come quella volta in cui suo padre l’ha accompagnata dalla ginecologa e questa, vedendoli in sala d’attesa, li ha scambiati per una coppia.
Coming out
Parlando delle reazioni dopo un coming out, Francesca mi ha detto che durante la sua prima visita con un nuovo ginecologo si è sentita chiedere chi, tra lei e la sua compagna, «facesse l'uomo» nella coppia.
Marta e Agnese preferiscono non esplicitare il loro orientamento sessuale durante le visite, lasciando implicitamente valida l’ipotesi di eterosessualità fatta dai medici.
Elena e Claudia mi hanno invece parlato di situazioni in cui la ginecologa di turno si è mostrata in imbarazzo o presa alla sprovvista. Una per esempio non ha saputo dare indicazioni precise sui test per le infezioni sessualmente trasmissibili (perché sì, naturalmente anche le donne saffiche sono a rischio ma se ne parla molto meno). Un’altra dottoressa invece si è infastidita durante il Pap test, quando Claudia, incalzata da domande che presumevano l’eterosessualità, le ha detto di non avere risposte utili in quanto lesbica:
La sua reazione non la dimenticherò mai. Mi ha detto, anche in tono un po' acceso: "Lei non ha necessità di dirmi il suo orientamento sessuale, se vuole dirlo va bene, ma non ce n'era bisogno".
Ah no? 😓
Molti altri temi sommersi
La metà delle mie amiche — e io stessa — ricorda situazioni in cui ci si è sentite costrette o inclini a nascondere la propria identità sessuale durante le visite mediche, per timore di essere giudicate o trattate diversamente.
Ci sono poi altri temi che hanno segnato le nostre esperienze con la ginecologia e che intersecano orientamento sessuale, genere ed età.
In generale, tutte vorremmo che il personale medico fosse inclusivo in modo proattivo e contemplasse l’idea che il mondo non è eterosessuale di default.
Abbiamo pensato a quanto sarebbe bello percepire più consapevolezza sull’identità di genere e vedere inclusa immediatamente la non binarietà come possibilità. Qui voliamo alto.
Per il momento, come ricorda anche Roberta, ci sono ancora temi che negli ambulatori ginecologici si trattano pochissimo:
Non ho mai sentito parlare di PrEP in nessun ambulatorio in cui sono stata, né di condom femminili.
A volte manca il consenso prima di determinati esami, anche invasivi, come il PAP test, dice Elena. Altre volte dobbiamo perdere tempo a giustificare le nostre scelte, come quella di non avere figli — «quante volte mi è stato detto “cambierai idea, vedrai” oppure “è un peccato, sei molto fertile!”», ricorda Agnese.
Capita poi di notare una mancanza di volontà di esplorare fino in fondo i problemi che riportiamo. Una di noi ha sofferto di cistite recidivante per circa un anno e mezzo e non c’era verso di capirne il motivo. Solo dopo mille ricerche fai-da-te è emersa l’ipotesi che il problema fosse di natura sessuale e legato alla salute del pavimento pelvico:
Avrei voluto che mi fosse chiesto come si sentivo, in relazione al problema e durante i rapporti (per esempio, se avessi problemi con la lubrificazione). Avrei voluto che una figura professionale mi aiutasse a capire cosa stava succedendo, anziché liquidarmi con la solita frase: “dalle analisi sembra tutto a posto”.
Le nostre esperienze non fanno scuola, ma danno un assaggio del panorama di pregiudizi e superficialità che costellano ancora il rapporto paziente-personale medico per chi non rientra nell’eteronorma.
Conclude lo stesso anche la guida sintetica di Porte Aperte! (il link apre direttamente il pdf) , corollario dell’indagine più ampia di cui ti ho parlato in apertura:
Vi sono delle prove evidenti sulle disparità sanitarie e i bisogni di salute delle donne lesbiche e bisessuali. Numerosi studi hanno dimostrato che le donne omo e bisessuali devono affrontare ineguaglianze sostanziali, sia nel campo della salute fisica sia in quello della salute mentale. […]
Lo stereotipo che considera le donne meno interessate al sesso, e non “vero sesso” quello tra donne, ha portato a una ridotta letteratura medica sulla salute sessuale delle donne lesbiche e bisessuali.Inoltre, tale credenza ha come conseguenza un minor numero di test, su questa collettività, per le malattie [sic] sessualmente trasmesse nonché il rischio di diagnosi errata per alcune malattie: per esempio, diagnosticare un’infezione alle urine laddove invece potrebbe essere presente la gonorrea, ciò a causa di una concezione eteronormativa del sesso per cui la gonorrea viene testata solo sulla cervice uterina.
Eccoci: gli stereotipi portano a scarsa prevenzione, errata interpretazione dei sintomi e problemi medici più frequenti. Ah, signora mia, quanto sarebbe bello rivoluzionare l’educazione sessuale e ampliarla, ampliarla, ampliarla per includere davvero tutte le persone!
Sul perché cambiare il linguaggio apre nuove finestre sulla realtà — LGBTQIA+ ma non solo — avevo parlato anche in questo episodio di Ojalá:
Letture e visioni per continuare a esplorare
LOVE LIFE è la campagna 2024 di promozione del «safer sex» dell’Ufficio federale della sanità pubblica svizzero. Il messaggio è semplice: il sesso è più sicuro quando ci si testa per le infezioni sessualmente trasmissibili (IST).
Rimango in Svizzera con una bellissima risorsa in italiano: Su tutte le labbra, guida pop sulla salute sessuale per persone lesbiche, bisessuali, pansessuali e queer. È realizzata da Salute Sessuale Svizzera, l’Organizzazione Svizzera delle Lesbiche e Aiuto Aids Svizzera. Bella da leggere e molto completa!
La medicina è un terreno neutrale?
parte da questa domanda per approfondire il tema dei bias e delle discriminazioni di genere in medicina.Il periodico memo per consigliare l’iscrizione a Diritti Sessuali, la newsletter di
per imparare a prenderci cura della nostra salute sessuale. Qui per esempio trovi la mappa di checkpoint e centri italiani dove fare i test per HIV e altre IST.Gioia queer è una delle mie espressioni preferite, per cui non potevo non consigliarti il Queer Joy Manifesto di Oxfam. Contiene anche belle illustrazioni da scaricare. 🌈
⏸️ Se apprezzi il mio lavoro e leggi con interesse Ojalá, hai mai pensato di sostenerla economicamente? Con 40 euro sostieni questo progetto per dodici mesi: in cambio hai accesso alla mia biblioteca digitale con le risorse che alimentano questo progetto.
Come suonerebbe questo episodio di Ojalá?
Tutta la musica che consiglio su Ojalá atterra su questa playlist collaborativa su Spotify. Che canzone assoceresti a questo episodio? Io non ho dubbi: Guess di Charli xcx e Billie Eilish.
Scrivimi la tua via email o nei commenti di Substack. 🎶
Per questa settimana chiudo qui.
Vuoi scrivermi cosa ne pensi di questa newsletter, propormi una collaborazione o semplicemente mandarmi un saluto?
Rispondi a questa email o scrivimi su ojala [at] aliceorru.me 📧
Sono Alice Orrù, sarda emigrata a Barcellona nel 2012.
Fiera della sua residenza, la mia newsletter contiene incursioni di vita catalana e tanta, tanta salsa brava. 🍟
Se ormai conosci Ojalá e apprezzi il mio lavoro, dai un’occhiata al piano a pagamento: con 40 euro sostieni questo progetto per un anno intero e hai accesso a tutte le risorse originali, passate e presenti, che condivido.
Grazie per aver letto fino a qui. 💙
Alice







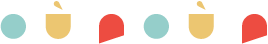
concordo! è anche rarissimo trovare professionistɛ che sappiano cosa significa asessuale e lo rispettino per ciò che è, cioè un orientamento sessuale e non qualcosa da patologizzare necessariamente. inoltre a me, da persona non binary, urta anche il fatto che, per esempio nelle brochure destinate a persone AFAB, si usi solo la parola "donna" e che immancabilmente siano rosa o tutt'al più violette, richiamando un immaginario rigorosamente binario, pure un po' infantilizzante. forse un po' meno stereotipi gioverebbero!
Santa pace, direbbe una mia amica! Mentre leggevo queste testimonianze, mi interrogavo su come potrebbe essere la situazione negli Stati Uniti, che lungi da essere un'oasi felice sulla salute femminile e LGBTQ+, è comunque un po' più "avanti" del Sud Europa nella maniera in cui si concepisce l'esistenza di identità e orientamenti diversi da quelli imposti dalle strutture patriarcali e religiose. Ricordo le facce giudicanti delle ginecologhe di un consultorio di Milano... niente a che vedere con l'accoglienza ricevuta negli Stati Uniti. Anche i formulari di entrata sono inclusivi della molteplicità di orientamenti relazionali/sessuali o modalità di fare sesso... o così almeno sembrano dal mio punto di vista eterocis: mi incuriosisce capire come se è così anche dal punto di vista di chi non si identifica come eterocis. Farò qualche ricerca! Grazie di questo episodio importantissimo!